Bartolo Longo, fondatore del santuario di Pompei – Chi propaga il Rosario è santo! (Cammini di santità #53)
 |
| Fonte |
Avevo
pensato di dedicare a lei l’articolo per il mese di settembre e di parlare
invece, a ottobre, di Bartolo Longo, pensando di rimandare a dopo la
canonizzazione, qui sul blog, il racconto aggiornato del mio legame con lui.
Il
direttore mi ha però comunicato di aver cambiato programma: il numero di
settembre non avrebbe ospitato la mia rubrica, perché interamente dedicato al
nuovo Rettor Maggiore (il superiore generale dei Salesiani di Don Bosco) e alla
Famiglia Salesiana in genere.
In
compenso, essendo ottobre il mese delle missioni, l’articolo su suor Troncatti
non solo sarebbe stato presente, ma in versione raddoppiata, quindi su quattro
pagine invece delle solite due e come articolo di primo piano. Anche quello su
Bartolo Longo sarebbe comparso nello stesso numero, nella solita collocazione.
Mi sono
quindi messa d’impegno su due fronti, oltre a quelli dovuti alle altre
collaborazioni che ho in corso. Se per suor Troncatti dovevo ancora leggere e
documentarmi, con Longo mi sentivo di padroneggiare di più la materia, ma
sapevo di non dover dare nulla per scontato, pensando sempre che la rivista e
il post che avrebbe ripreso l’articolo avrebbero potuto arrivare a qualcuno che
non conosce affatto la sua storia, né quella del santuario di Pompei e delle
opere annesse, tutte fondate da lui.
Per
cambiare un po’ la mia esposizione rispetto ad altri articoli usciti dopo la
notizia della canonizzazione con dispensa dal miracolo, ho pensato di riferirmi
al rapporto, storicamente accertato, tra Longo, san Giovanni Bosco e il Beato
Michele Rua, primo Rettor Maggiore salesiano. In questo è stato preziosissimo
uno dei lavori di don Ivan Licinio, vicerettore del santuario, a cui ho mandato
l’articolo per correttezza; l’ho fatto anche con i giornalisti che ora
collaborano alla rivista Il Rosario e la Nuova Pompei. Da tutti ho
ricevuto complimenti che non sento di meritare interamente: ho commesso qualche
piccolo errore, ma sento di aver lavorato davvero per dar gloria alla Madonna e
a Dio, più o meno come aveva fatto l’ancora per poco Beato.
Com’è nel
mio modo di fare, questo post ha, appunto, ancora l’etichetta “Beati”,
unicamente per rispettare il fatto che Bartolo può essere chiamato Santo dal
momento in cui il Papa lo dichiarerà tale, non prima. Nel titolo, invece, “santo”
ha la minuscola: è una ripresa della frase a cui faccio riferimento nel primo
paragrafo e campeggiava sullo striscione appeso al Municipio di Pompei l’ultima
volta che sono passata di lì, lo scorso 14 maggio.
Pensavo
però che sarebbe stato ottimo riprendere qui l’articolo proprio oggi, giorno
della sua nascita al Cielo (corrisponderebbe anche al giorno della memoria
liturgica, ma è domenica) e, in quanto prima domenica di ottobre, occasione in
cui a Pompei viene solennemente recitata la Supplica alla Beata Vergine del
Rosario.
* * *
È un giorno di ottobre dell’anno 1872. L’avvocato Bartolo Longo si trova da qualche tempo a Valle di Pompei, come amministratore dei possedimenti della contessa Marianna Farnararo, da poco rimasta vedova. Sin dall’inizio della sua permanenza si è reso conto della miseria in cui vivono gli abitanti della zona: non ci sono scuole e i bambini sono abbandonati a sé stessi; perfino la religiosità degli abitanti è ai limiti della superstizione. Quanto a lui, ha ritrovato da tempo la fede, ma il ricordo della sua vita passata torna spesso a tormentarlo. Anche il futuro gli sembra oscuro: i tentativi di matrimonio sono sfumati, mentre lo stato religioso sembra non fare per lui.
In preda
all’inquietudine, Bartolo esce di casa e inizia a camminare senza meta, fino ad
arrivare in un luogo chiamato Arpaja, forse perché, per il suo squallore,
ricorda la tana delle mitologiche Arpie. Lì si ferma di botto, col cuore
oppresso dall’angoscia. Proprio in quel punto, però, crede di riascoltare le
parole che tante volte gli aveva ripetuto il suo direttore spirituale: «Se
cerchi salvezza, propaga il Rosario. È promessa di Maria. Chi propaga il
Rosario è salvo!». Quel ricordo è come un lampo che squarcia la notte dei suoi
pensieri: «Se è vero», grida rivolto alla Madonna, «che tu hai promesso a San
Domenico che chi propaga il Rosario si salva, io mi salverò perché non uscirò
da questa terra di Pompei senza aver qui propagato il tuo Rosario!». Un
silenzio inaspettato segue le sue parole, accompagnato da una repentina calma
interiore: Bartolo intuisce che un giorno quel grido sarà esaudito. Di lì a
poco, da lontano, sente suonare le campane dell’Angelus di mezzogiorno.
Dall’anticlericalismo
al ritorno alla fede
Bartolo nasce a Latiano, in provincia di Brindisi e diocesi di Oria, il 10 febbraio 1841. A sei anni viene mandato dai genitori al Real Collegio Ferdinandeo di Francavilla Fontana: sotto la guida dei padri Scolopi, consolida la religiosità che già viveva in famiglia e diventa uno dei migliori allievi. Successivamente intraprende la carriera da avvocato, studiando a Lecce e quindi a Napoli.
Tuttavia, nei corsi
universitari che frequenta, sente sempre più raccontare che Gesù non è il
Figlio di Dio, ma solo un uomo eccezionale, secondo quanto sostengono vari
esponenti dell’anticlericalismo. I principi a cui Bartolo è stato educato
iniziano a sgretolarsi, ma rimane in lui una certa attrattiva verso il
soprannaturale: per questa ragione, accetta di partecipare ad alcune riunioni
in cui si afferma che vengono evocati gli spiriti dei defunti. Il 12 dicembre
1864 si laurea, ma continua ad essere inquieto e a partecipare a quelle
riunioni.
La sua situazione
cambia grazie all’amico Vincenzo Pepe, che da una parte lo rimprovera,
dall’altra l’invita a ricorrere ai consigli spirituali del domenicano padre
Alberto Radente. Il 29 maggio 1865 ha il suo primo colloquio con lui: circa un
mese dopo, il 23 giugno, quell’anno solennità del Sacro Cuore di Gesù, si
riaccosta alla Comunione. Consolida il suo rinnovato rapporto con Dio
diventando Terziario domenicano, col nome di fra’ Rosario, e iniziando a
frequentare circoli ben diversi da quelli dello spiritismo, ossia le conferenze
spirituali e i Cenacoli di preghiera guidati da una nobile napoletana, Caterina
Volpicelli.
Nasce il santuario
di Pompei
Proprio Caterina mette in contatto Bartolo con la contessa Marianna, che gli offre una proposta lavorativa: deve amministrare i possedimenti ereditati dal marito, il conte Albenzio De Fusco, a Valle di Pompei. È la stessa cittadina dove, da meno di un secolo, sono riemerse le rovine della Pompei romana, distrutta dall’eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo.
Dopo l’esperienza
dell’ottobre 1872, Bartolo decide di dedicare interamente la sua vita a far
conoscere e amare la Vergine Maria, particolarmente attraverso la preghiera del
Rosario. Incoraggiato dal vescovo di Nola, monsignor Giuseppe Formisano, sotto
la cui giurisdizione ricade Valle di Pompei, parte col chiedere agli abitanti
un soldo al mese per ricostruire la fatiscente chiesetta parrocchiale. Inizia a
insegnare il catechismo, ma anche a leggere e a scrivere, ai figli dei
contadini. Organizza feste popolari, distribuisce largamente corone del Rosario
e oggetti religiosi, ma continua a pensare che la Madonna e quella gente
meritano di più.
Il 13 novembre 1875
arriva, su di un carro carico di letame, un quadro della Madonna del Rosario,
che Bartolo si è procurato attraverso i suoi amici religiosi. Inizialmente
sembra brutto, ma col tempo e grazie a un primo restauro acquista uno splendore
che attrae anche i contadini. Il giorno dopo, al termine della missione
popolare per la quale ha fatto arrivare il quadro, Bartolo riceve un
suggerimento dal vescovo Formisano: costruire una chiesa nuova. Dopo anni di
lavori, di progetti, di elemosine chieste e ricevute, il 7 maggio 1891 viene
consacrato il santuario tanto desiderato.
Don Bosco e don Rua tra i “santi
viventi” suoi amici
Alla costruzione del santuario, Bartolo, insieme alla contessa Marianna che continua a sostenerlo, affianca subito la prima opera di carità: un orfanotrofio femminile, per educare le bambine e le ragazze fino alla maggiore età. A quella struttura si aggiunge l’ospizio per i figli dei carcerati, nato dall’incontro tra l’avvocato e un detenuto che non sapeva a chi affidare i suoi bambini.
Per avere un aiuto
nell’educazione di quei ragazzi e ragazze, Bartolo pensa di ricorrere a don
Giovanni Bosco, che va a incontrare nel maggio 1885. Prende spunto da lui e dal
Bollettino
Salesiano nel rendere
gratuito il periodico Il Rosario e la
Nuova Pompei, che aveva fondato
l’anno precedente. Resta in contatto con i Salesiani anche dopo la morte del
fondatore: il 6 gennaio 1892 scrive a don Michele Rua, il primo Rettor
Maggiore, per interpellarlo circa la nascita di un orfanotrofio maschile. Nella
stessa lettera, gli confida: «Nel giorno di Natale mi è parso che il Cuore di
Gesù voglia affidare questa nuova fondazione ai Figli di Don Bosco. Se questa è
un’illuminazione o un’ispirazione dal cielo, me lo dirà la Paternità Vostra
Reverendissima». Don Rua visita il santuario, ma alla fine, per varie
questioni, la presenza salesiana, sia maschile sia femminile, non viene
concessa. Bartolo, dunque, diventa anche fondatore di una congregazione
religiosa, le Figlie del Rosario di Pompei, di spiritualità domenicana. Don
Bosco e don Rua sono solo alcuni dei
“santi viventi” che Bartolo conosce nel corso della sua vita. Alcuni, come
quelli citati, sono già stati beatificati o canonizzati, come anche la già
citata Caterina Volpicelli o il francescano padre Ludovico da Casoria, che gli
insegnò a vivere la carità verso i ragazzi abbandonati.
La sua eredità: carità e preghiera
Per mettere a tacere le voci circa il loro rapporto, Bartolo e la contessa Marianna accettano di unirsi in matrimonio il 1° aprile 1885. Nel 1893, sempre a causa di voci malevole, lui cede a papa Leone XIII la proprietà del santuario e di tutte le opere pompeiane e, qualche anno più tardi, rinuncia anche all’amministrazione. Ormai spogliato di tutto, osserva la crescita del santuario e le vite rinnovate di tanti orfani e orfane, ma anche della stessa cittadina, che diventerà Prelatura territoriale prima, poi Comune autonomo col solo nome di Pompei.
Bartolo muore il 5
ottobre 1926, preceduto, il 9 febbraio 1924, dalla moglie. Nel 1900, dalle
pagine de Il Rosario e la
Nuova Pompei, aveva sintetizzato
così l’esperienza pompeiana: «Il Santuario di Pompei si differisce precipuamente
dagli altri Santuari, perché qui la Carità è il carattere proprio di
quest’opera che eccede le forze umane». Alla carità si unisce la preghiera,
attraverso il Rosario, ma anche con le forme ideate o riprese da Bartolo
stesso: le principali sono i Quindici (poi Venti) Sabati del Santo Rosario e la
Supplica alla Beata Vergine del Rosario di Pompei, recitata in tutto il mondo a
mezzogiorno (la stessa ora del grido di quel lontano ottobre 1872) dell’8
maggio e della prima domenica di ottobre.
Bartolo è stato
beatificato da san Giovanni Paolo II 26 ottobre 1980; la sua canonizzazione,
con dispensa dal secondo miracolo, è stata fissata al 19 ottobre 2025. Subito
dopo il Concistoro in cui papa Leone XIV
ha stabilito la data, monsignor Tommaso Caputo, arcivescovo prelato di Pompei,
ha riunito la comunità religiosa e civile pompeiana nella cappella in cui, dal
2000, sono venerate le spoglie dell’«avvocato della Madonna», per invitare a «rendere
grazie al Signore, nostro Dio, il cui amore ha cambiato il cuore di un uomo
che, da peccatore, è diventato santo».
Originariamente
pubblicato su «Sacro Cuore VIVERE» 6 (ottobre 2025), pp. 22-23 (consultabile qui)
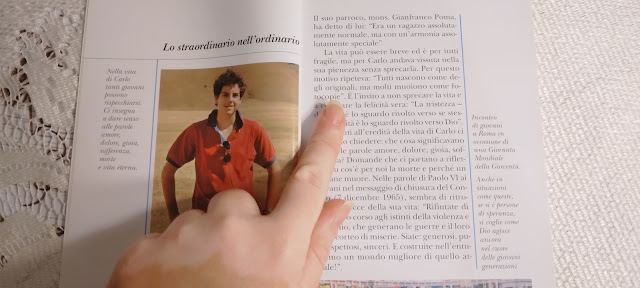
Commenti
Posta un commento