Padre Placido Cortese, messaggero di carità
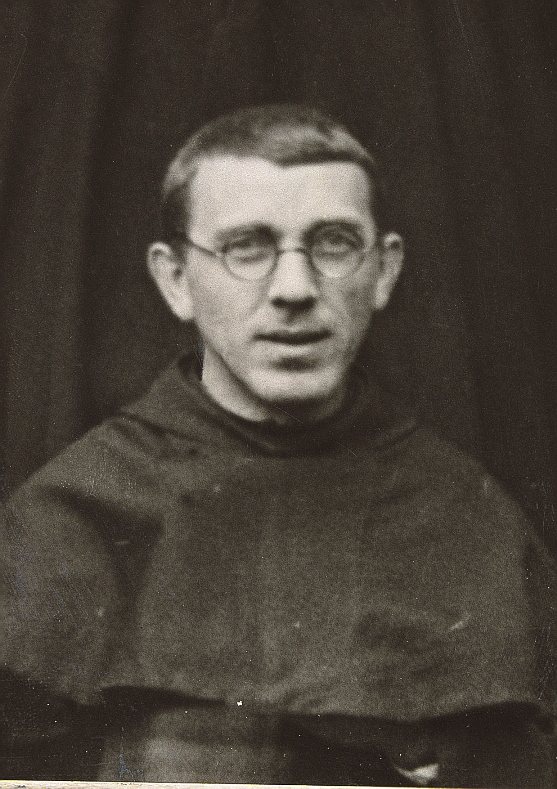 |
| La foto ufficiale scelta per la Positio (fonte) |
Nicolò Matteo Cortese nacque a Cherso in Croazia, al tempo parte dell’impero austro-ungarico, il 7 marzo 1907, figlio primogenito (di quattro) di Matteo Cortese e Antonia Battaia.
Nel
1920 entrò nel Seminario dei Frati Minori Conventuali a Camposampiero, in
provincia e diocesi di Padova; tre anni dopo, iniziò il noviziato a Padova,
diventando fra Placido. Professò i voti religiosi il 10 ottobre 1924.
Tornò a
Cherso per frequentare il liceo nel Collegio di San Francesco, quindi, nel 1927,
fu inviato a Roma, all’Istituto Teologico San Bonaventura, l’attuale Seraphicum:
oltre agli studi teologici, cominciò a fare pratica di giornalismo, scrivendo
sul bollettino della basilica di Santi XII Apostoli. Il 6 luglio 1930 fu
ordinato sacerdote.
Tornato
a Padova, nel 1933 entrò a far parte a pieno titolo della comunità dei frati
nella basilica di Sant’Antonio, detta popolarmente “Il Santo”, con vari
incarichi: confessore, ma anche redattore de «Il Messaggero di Sant’Antonio»,
nel quale si occupava soprattutto della rubrica delle lettere.
A
dicembre dello stesso anno, padre Placido venne inviato al convento
dell’Immacolata e Sant’Antonio a Milano, in viale Corsica, dove seguì, tra
l’altro, i lavori di costruzione della nuova chiesa parrocchiale.
Nel
1937 tornò a Padova, questa volta come direttore del «Messaggero». Nello stesso
anno fu nominato Custode della Provincia Patavina dei Frati Minori Conventuali.
Nel 1940 fu trasferito nel convento di San Francesco a Cherso.
Poco
dopo il suo ritorno a Padova, tre studentesse slovene, Majda Mazovec, Marija
Slapšac e Marja Ujčič, entrarono in contatto con lui. Majda gli chiese di
aiutare gli internati del campo di prigionia di Chiesanuova: dopo un’iniziale
riluttanza, padre Placido accettò. Nel 1942 quel compito gli fu confermato da
monsignor Francesco Borgoncini Duca, Nunzio apostolico in Italia e delegato
pontificio per la basilica di Sant’Antonio.
Negli
anni seguenti, padre Placido estese il suo impegno contribuendo a far fuggire
dall’Italia molti ebrei e, dopo l’8 settembre 1944, anche ex prigionieri
inglesi e alleati; quest’ultima scelta avvenne dopo che lui era diventato parte
di Fra.Ma., rete clandestina capeggiata dagli intellettuali Ezio Franceschini e
Concetto Marchesi. La Gestapo cominciò a seguire con preoccupazione i movimenti
di padre Placido, ma non riuscì ad arrestarlo nel convento, che godeva
dell’extraterritorialità, essendo territorio vaticano.
L’8
ottobre 1944, verso le 13.30, padre Placido fu visto uscire dal convento: da
allora se ne persero le tracce. Col tempo è emerso che era caduto in una
trappola ordita da alcuni tedeschi che si erano finti bisognosi di espatriare,
i quali l’avevano convinto a incontrarlo fuori dalle mura del Santo.
Fu
condotto nel bunker della Gestapo di piazza Oberdan a Trieste, dove venne
torturato e picchiato fino alla morte, avvenuta presumibilmente nei primi
giorni di novembre. Non è stato possibile ritrovare i suoi resti mortali:
l’ipotesi più probabile è che siano stati cremati nel forno della Risiera di
San Sabba.
La sua
causa di beatificazione e canonizzazione fu inizialmente impostata per la
verifica del martirio in odio alla fede: l’inchiesta diocesana si svolse a
Trieste dal 29 gennaio 2022 al 15 ottobre 2003. Sempre a Trieste fu celebrata
un’inchiesta suppletiva, questa volta sulle virtù, dal 18 giugno al 25 ottobre
2012, perché la Congregazione delle Cause dei Santi aveva richiesto di cambiare
impostazione alla causa, ritenendo l’asserito martirio non sufficientemente
fondato sul piano teologico. Il 30 agosto 2021 papa Francesco autorizzò il
decreto sulle virtù eroiche di padre Placido.
Cosa
c’entra con me?
Nella
valanga di santini che un mio corrispondente m’inviò, più o meno una decina
d’anni fa, non c’era solo quello del Beato Carlo d’Austria, per esempio, ma
anche un segnalibro che attrasse subito il mio interesse (non che le altre
immagini mi fossero meno gradite): ritraeva padre Placido, con la schiena
rivolta a un cancello e, sullo sfondo, la basilica di Sant’Antonio a Padova.
Soprattutto, veniva menzionato come “martire della carità” sia sul fronte, sia
sul retro del segnalibro. Non credo di aver mai sentito parlare di lui prima di
allora, ma al momento non mi venne l’idea di fare ricerche sul suo conto.
L’ultima
volta che sono stata alla basilica del Santo, insieme ai miei familiari, mi è
tornato alla mente, vedendolo comparire sulla copertina di un piccolo libro.
Era un’occasione davvero imperdibile, così ho preso quel volumetto insieme ad
altri ricordini. Non ricordo le impressioni che avevo ricevuto in quella
circostanza, salvo forse un po’ di delusione: contrariamente ad altre
pubblicazioni della medesima collana, infatti, non dava molto spazio alla
biografia in senso stretto di quel frate.
Il 30
agosto 2021, leggendo il suo nome nei Decreti dell’allora Congregazione delle
Cause dei Santi, sono rimasta leggermente perplessa: non era stato riconosciuto
il suo martirio, ma l’eroicità delle virtù. Avevo quindi bisogno di
chiarimenti per aggiornare la sua scheda sull'Enciclopedia dei Santi, Beati e Testimoni, che neppure il fornitissimo sito ufficiale riusciva a darmi, dato
che continuava a considerarlo “martire della carità”.
Il
vicepostulatore mi offrì l’aiuto di cui avevo bisogno: la causa era stata
avviata per martirio, ma la Congregazione delle Cause dei Santi aveva chiesto
di passare alla via delle virtù, in quanto il martirio non appariva sufficientemente
fondato dal punto di vista teologico. Questo, però, non impediva che, se fossero
emersi documenti e testimonianze davvero schiaccianti, si potesse tornare sulla
via iniziale. Potrebbero sembrare cavilli inutili, se quel che conta è la
testimonianza cristiana di padre Placido, ma volevo essere sicura, per
raccontare con verità il suo percorso verso gli altari.
Padre
Placido è rispuntato nella mia vita nel corso del lavoro di revisione e
aggiornamento del libro Nuovi Martiri, in collaborazione con l’autore,
Luigi Accattoli, e con Ciro Fusco che ne cura la postfazione (per chi se lo
stesse chiedendo: avevo sbagliato a riferire che sarebbe uscito a ottobre,
perché questo, invece, è il mese in cui verrà consegnata la bozza più o meno
definitiva).
Era
censito nel capitolo “Martiri dell’aiuto agli ebrei” e, ovviamente, non si
faceva menzione della causa: solo quattro anni prima, infatti, avevano
cominciato ad emergere le testimonianze che avrebbero portato ai primi passi
per l’avvio dell’inchiesta diocesana.
Il suo
caso è stato uno dei primi a essermi venuti in mente, quando Accattoli mi ha
incaricata di segnalare a lui e a Fusco i personaggi per i quali si sono aperte
le cause, dal 1999 a oggi, o per i quali sono arrivate le beatificazioni e le
canonizzazioni.
Grazie
a quel lavoro, mi sono appuntata che oggi ricorreva l’ottantesimo anniversario
della sua scomparsa, termine che, nel suo caso, non è un eufemismo per indicare
la morte. Ho quindi immaginato di parlare di lui anche qui, non prima, però, di
aver riletto il libro preso a Padova.
Con una
consapevolezza maggiore, ho cambiato il mio giudizio: molte di quelle
testimonianze, nell’anno di pubblicazione, erano di fatto inedite e quindi
preziosissime. La vita di padre Placido filtrava attraverso di esse, con tutta
la sua carica di tenacia, di furbizia perché no, d’impegno a compiere quanto
più possibile il bene per tutti quei prigionieri, sbandati, perseguitati che,
senza il suo contributo, sarebbero andate incontro a una morte sicura.
Ho poi
ricordato un particolare che, alla prima lettura, non poteva non avermi
colpita: anche lui è tra i candidati agli altari affiliati, per così dire, alla
diocesi di Milano (qui l’elenco, in costante aggiornamento, dei Santi, Beati, Venerabili, Servi di Dio
e Testimoni ambrosiani per origine, per morte o per aver trascorso parte della
vita nel territorio diocesano).
C’è
anche una foto che lo ritrae, riconoscibile per i suoi occhiali tondi, alle
spalle del Beato Alfredo Ildefonso Schuster, al tempo arcivescovo: immagino
risalga alla consacrazione della chiesa di viale Corsica, che io stessa ho
visitato in più di un’occasione. Da parecchio non passo più di lì: se me ne
fossi ricordata prima, avrei potuto chiedere ai frati se l’avrebbero
commemorato in qualche modo.
Consultare
il sito della sua causa, in preparazione a questo post, mi ha aiutato a trovare
le affinità che intercorrono tra me e lui. Anch’io, infatti, ho alloggiato al
Seraphicum nel pellegrinaggio per la canonizzazione di Charles de Foucauld, nel
2022, come raccontavo qui.
Ancora
meglio, anch’io non sono una giornalista professionista: scrivo solo perché
voglio far conoscere la gloria di Dio nei Santi riconosciuti e nei Testimoni
che molti considerano tali, ma di cui non è aperta (e forse non lo sarà mai) la
causa. Anche padre Placido ha scritto articoli su molti Santi e Beati: alcuni sono molto
cari anche a me, come san Giuseppe da Copertino (qui il mio post) e sant’Antonio di
Padova (idem).
Su di
un altro piano della Comunione del Santi, lui è stato in relazione diretta con
almeno un Santo vivente del suo tempo, padre Leopoldo Mandić, Cappuccino: in occasione della sua morte, gli
dedicò un editoriale. Sempre in ambito cappuccino, san Pio da Pietrelcina fu
interpellato da padre Fulgenzio Cappello, altro collaboratore di padre Placido,
circa la sua sorte: la risposta fu che era «in paradiso per la sua grande
carità», secondo quanto riferì suor Giustina Fasan.
Il
suo Vangelo
Padre Placido non si è improvvisato mezzo di salvezza per tutte quelle persone: anzi, inizialmente non voleva nemmeno farlo, convinto com’era che nel campo di Chiesanuova ci fossero solo comunisti. Le insistenze di Majda Mazovec gli fecero cambiare idea, riconoscendo che, al di là delle appartenenze politiche, quelli erano uomini che soffrivano, suoi fratelli.
A quel
punto ha inventato una serie di stratagemmi: indossare più abiti sotto il saio
prima di partire per il campo, oppure prendere le foto dagli ex voto lasciati
presso l’Arca del Santo (l’urna con la maggior parte delle ossa di sant’Antonio)
per realizzare i passaporti falsi. Una creatività seconda solo a quella
impiegata negli articoli per il «Messaggero di Sant’Antonio», dove si firmava “Padre
Messaggero”: tale fu, di fatto, per molte volte, al di là dell’attività
editoriale. Di conseguenza, l’attenzione e la carità verso chi è in bisogni
veramente gravi costituisce l’annuncio evangelico principale che deriva dalla
sua testimonianza.
Con
tutti quegli aiuti, padre Placido poteva offrire a quelle persone una speranza,
in mezzo alla guerra e alle persecuzioni. Era la stessa speranza che infondeva alla
sorella Giovanna Antonia, detta Nina, nella lettera del 19 novembre 1928,
quando (non era ancora sacerdote) da pochi giorni aveva perso, quasi in un
colpo solo, il padre e il fratello Matteo:
Cosa faremo in queste
ore di sconforto e di pianto? Ci daremo forse alla disperazione? O rivolgeremo
in alto gli occhi per mirare in una speranza che non viene meno e che dà quello
che promette? Sì, io ho innalzato gli occhi in alto, e vedo quel beato luogo
dove il Signore asterge dagli occhi dei suoi servi ogni lagrima, dove non vi è né
lutto, né pianto
[…] Questa è la più bella speranza che ci possa unire a lui perché egli da
lassù ci guarda e ci aspetta.
Sono
parole che non valgono solo per quel momento luttuoso, ma che possono essere
applicate a tutte quelle situazioni difficili che molti vivono ancora oggi.
Per
saperne di più
Apollonio Tottoli, Padre Placido Cortese vittima del nazismo, Edizioni Messaggero Padova 2020, pp. 296, € 20,00.
Terza
edizione della biografia uscita nel 2002, che era stata commissionata per l’avvio
della causa.
Cristina Sartori, Padre Placido Cortese, Edizioni Messaggero Padova 2010, pp. 136, € 9,00.
Il
racconto della sua azione di carità dalla viva voce dei testimoni.
Su
Internet
Sito ufficiale della sua causa, con approfondimenti, le sue lettere e le notizie circa la diffusione della sua memoria
Pagina su di lui sul sito del Dicastero delle Cause dei Santi col profilo biografico e il testo del decreto sulle virtù

Commenti
Posta un commento